Il cinema nipponico e i samurai
La scarsa attenzione che il cinema occidentale dedica alle produzioni orientali, he spesso impedito nel corso degli anni la conoscenza di vere e proprie gemme o l’incontro con personalità di altissimo livello. Questa cortina di bambù, la cui costruzione è da imputare a tutte e due le parti (oriente e occidente), è stata infranta per la prima volta da Akira Kurosawa, il primo regista ad ottenere il risalto necessario anche alle nostre latitudini. Da allora, qualcosa riesce a trapelare, ma viene intercettato per lo più da affezionati cinefili e non sempre raggiunge il pubblico più vasto.
Fra gli autori più interessanti del cinema nipponico, non possiamo non citare Takashi Miike, vero eroe controcorrente e cineasta fra i più fertili di tutti i tempi. Miike infatti si è dimostrato capace di sfornare 4-5 film all’anno (numeri che, senza raggiungere gli opposti eccessi di Terrence Malick, sono pura fantascienza per Hollywood e simili!), destreggiandosi fra i generi con una capacità di trasformismo quasi eccezionale. Come un ronin, dopo aver abbandonato il proprio daimio (il cinema “di regime”), il regista ha deciso di usare la propria spada/cinepresa ora a favore e ora contro il suo pubblico, diventando, proprio come un samurai decaduto, ora eroe e ora assassino. Non ha mai dimenticato, però, l’entusiasmo e quella sorta di sarcasmo divertito con cui sembra ammiccare ogni volta che si guarda un film della sua produzione ormai più che ventennale.
 Il primo successo, anche alle nostre latitudini, gli è stato consegnato dalla serie di Dead or Alive, polizieschi incentrati sui due protagonisti, Ryuchi e il detective Jojima, e sulle vicende della malavita e della yakuza. Lontano dal sentimentalismo di Takeshi Kitano (altro ottimo regista suo connazionale), il primo DoA si configura come una dura storia di personaggi al limite, incorniciata all’interno di due momenti di altissimo cinema: la sequenza iniziale, un vero e proprio trattato di montaggio e regia, concentrato in pochi, frenetici minuti, e la scena finale, dalla quale emerge tutto il senso ironico del regista. Nell’esplosione che precede i titoli di coda, sembra quasi sentirlo ridere e ricordarci di non prendere mai nulla sul serio, a maggior ragione nei suoi film.
Il primo successo, anche alle nostre latitudini, gli è stato consegnato dalla serie di Dead or Alive, polizieschi incentrati sui due protagonisti, Ryuchi e il detective Jojima, e sulle vicende della malavita e della yakuza. Lontano dal sentimentalismo di Takeshi Kitano (altro ottimo regista suo connazionale), il primo DoA si configura come una dura storia di personaggi al limite, incorniciata all’interno di due momenti di altissimo cinema: la sequenza iniziale, un vero e proprio trattato di montaggio e regia, concentrato in pochi, frenetici minuti, e la scena finale, dalla quale emerge tutto il senso ironico del regista. Nell’esplosione che precede i titoli di coda, sembra quasi sentirlo ridere e ricordarci di non prendere mai nulla sul serio, a maggior ragione nei suoi film.
Proprio la sua capacità di ribaltare tutto con una sequenza di pochi istanti, di cambiare le carte in tavola o, meglio, di buttare all’aria il tavolo con tutte le carte sopra, costituiscono caratteristica fondamentale per comprendere il suo cinema. Ad ogni istante, guardando i suoi film, viene da chiedersi: “cosa mi combinerà questa volta? Avanti, Miike, fatti vedere!”. E raramente questa speranza viene disattesa. Così una storia d’amore diventa in Audition il set di torture inenarrabili (e inadatte ai palati sensibili), tutto sottintendendo come metafora la capacità reale di capire l’altro, di vedere realmente come sia fatto il nostro prossimo, levandoci l’idealizzazione dai nostri occhi. Vediamo il nostro partner per come siamo noi: ora idealizzandola a ragazza modello, ora rendendola una torturatrice sadica che applica aghi e corde per “mutilare” la capacità di tradimento dell’uomo.
Proprio sulla comprensione del dolore, sull’estetica di quest’ultimo, si basa il suo film più noto ai cultori del genere: Ichi the Killer, a cui si deve la creazione di uno dei cattivi meglio riusciti degli ultimi decenni, il sadico Kakihara. Ichi è un killer innocente, che uccide con le mosse imparate sui videogiochi, e crea non pochi problemi alla yakuza. Si oppone a lui Kakihara, malavitoso alla ricerca del piacere perfetto attraverso il dolore. È facile intuire come la cultura miscellanea in cui il regista è cresciuto (il Giappone dei samurai e dei fumetti manga, delle vecchie mitologie e degli anime che le riprendono e stravolgono, della cultura tradizionale imperiale e dell’invasione occidentale) abbia influenzato la sua produzione, fino a trasformarlo in uno dei massimi esponenti del postmodernismo al cinema.
 Così la sua vastissima produzione passa, con una sorta di nonchalance, quasi con distrazione, dagli horror psicologici come Gozu e Izo , a trasposizioni cinematografiche di anime e manga, come il fantasmagorico Yattaman (consigliato a tutti coloro che, per età o passione, conoscono l’omonimo anime), un piccolo gioiello di commedia fantastica; da drammi incentrati sulla scoperta della sessualità, come Big Bang Love, Juvenile A, a film sui “supereroi”, come la comica serie di Zebraman. Forse il più grande esempio di commistione di generi, di contaminazione elevata a paradigma, è Sukiyaki Western Django, una trama ripresa da Yojimbo di Kurosawa, ma diretta come fosse un vecchio spaghetti western (omaggiato doppiamente dal titolo: il sukiyaki è una pietanza di spaghetti e brodo giapponese; Django è il noto personaggio ideato da Sergio Corbucci), in cui Quentin Tarantino viene posto, quasi a suggello della postmodernità, nella splendida e surreale sequenza iniziale. Il tutto infarcito con una miriade di citazioni di Sergio Leone, Corbucci e molti altri noti registi del genere spaghetti western.
Così la sua vastissima produzione passa, con una sorta di nonchalance, quasi con distrazione, dagli horror psicologici come Gozu e Izo , a trasposizioni cinematografiche di anime e manga, come il fantasmagorico Yattaman (consigliato a tutti coloro che, per età o passione, conoscono l’omonimo anime), un piccolo gioiello di commedia fantastica; da drammi incentrati sulla scoperta della sessualità, come Big Bang Love, Juvenile A, a film sui “supereroi”, come la comica serie di Zebraman. Forse il più grande esempio di commistione di generi, di contaminazione elevata a paradigma, è Sukiyaki Western Django, una trama ripresa da Yojimbo di Kurosawa, ma diretta come fosse un vecchio spaghetti western (omaggiato doppiamente dal titolo: il sukiyaki è una pietanza di spaghetti e brodo giapponese; Django è il noto personaggio ideato da Sergio Corbucci), in cui Quentin Tarantino viene posto, quasi a suggello della postmodernità, nella splendida e surreale sequenza iniziale. Il tutto infarcito con una miriade di citazioni di Sergio Leone, Corbucci e molti altri noti registi del genere spaghetti western.
Menzione a parte meritano alcuni suoi film dedicati alla figura classica del samurai, uno dei quali, 13 Assassini, ha avuto l’onore di essere trasmesso anche nelle nostre sale, invece che arrivare direttamente in home video, come accade alla maggior parte dei suoi film. Si tratta dei pochi film che sono stati capaci di eguagliare per bellezza formale e purezza dell’idea i migliori film di genere di Kurosawa, ancora maestro indiscusso. Come anche Harakiri – death of a samurai, si tratta di film che parlano di un mondo ormai scomparso e poco noto, ma girati con un’intelligenza ed una modernità fuori dal comune e capace di renderli fruibili a tutti, senza rischiare incomprensioni o operazioni che rischiano il ridicolo (come è accaduto per gli inguardabili 47 Ronin di Keanu Reeves, incapaci anche di prendersi in giro). La figura del samurai è affrontata in tutta la sua complessità, non limitandosi ad una semplice ripresa dei valori del passato, ma attualizzandoli ed analizzandoli senza paura di scoprirli, talvolta, ormai obsoleti. Il tutto senza dimenticare i maestri (i 7 samurai vengono ampiamenti omaggiati nei 13 assassini) né la vena pulp ed ironica che caratterizza tutta la produzione di Miike: anatemi scritti da donne mutilate e tori incendiari sono solo alcuni degli stratagemmi escogitati nell’epica battaglia che occupa la seconda metà dei 13 assassini, dopo una prima parte dedicata alla conoscenza dei protagonisti, proprio come nei film classici di genere.
Il regista stesso sembra essere rappresentato nel tredicesimo “assassino”, unitosi al gruppo per caso e portatore di qualche mistero che lo renderà protagonista della scena finale, ancora una volta marchio di fabbrica di Miike, a ricordarci che si può scherzare anche coi valori alti del bushido e che prendersi poco sul serio è un’ottima maniera di sopravvivere, anche a se stessi.
Alessandro Pigoni




















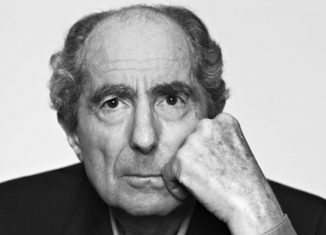
[…] La coreografia del duello, quasi una danza, è il fulcro del cortometraggio. Poesia in movimento, assecondata da un lucidissimo bianco e nero che sottolinea contrasti e colpi fra contendenti. Splendide fotografia e regia, che presentano i samurai prima attraverso i loro sguardi, dipanandone le vicende lungo le linee verticali ed oblique di alberi e spade. Basterebbero le due inquadrature di apertura e quella di chiusura per renderlo una piccola perla, ma ciò che sta in mezzo lo rende anche qualcosa di più, con niente da invidiare a Kurosawa o Miike. […]