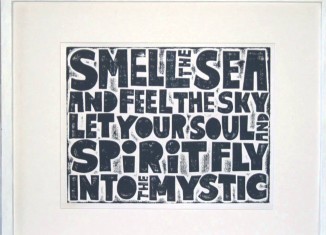#GiveMe5 (Mare Edition) | vol.170
“Ogniqualvolta mi accorgo di mettere il muso; ogniqualvolta giunge sull’anima mia un umido e piovoso novembre; ogniqualvolta mi sorprendo fermo, senza volerlo, dinanzi alle agenzie di pompe funebri o pronto a far da coda a ogni funerale che incontro; e specialmente ogniqualvolta l’umor nero mi invade a tal punto che soltanto un saldo principio morale può trattenermi dall’andare per le vie col deliberato e metodico proposito di togliere il cappello di testa alla gente — allora reputo sia giunto per me il momento di prendere al più presto il mare.
Questo è il sostituto che io trovo a pistola e pallottola. Con un ghirigoro filosofico Catone si getta sulla spada; io, quietamente, mi imbarco. Non c’è niente di straordinario in questo. Basterebbe che lo conoscessero appena un poco, e quasi tutti gli uomini, una volta o l’altra, ciascuno a suo modo, si accorgerebbero di nutrire per l’oceano su per giù gli stessi sentimenti miei” (Moby Dick, Herman Melville)
Tra le tante immagini associate al mare che porto dentro di me, quella più limpida e pacificante che mi venga in mente arriva dall’estate del 2010. Ero a Brighton, ospite di un amico che durante il giorno era impegnato al lavoro; avevo dunque ore e ore di totale solitudine da dedicare all’esplorazione di un posto in cui non ero mai stato. Ci misi poco a trovarmi un piccolo rituale: ogni mattina andavo sulla spiaggia – non il più bel mare del mondo, ecco – e rimanevo lì per lunghi minuti a osservare le onde prendere la rincorsa per arrivare giusto a pochi metri dai miei piedi.
A farmi compagnia, in cuffia, c’era Salvador Sanchez di Sun Kil Moon. Non c’entrava nulla col mare – il brano ricorda con dolcezza e malinconie alcuni pugili morti troppo giovani – ma il suono gargantuesco e placido di quelle chitarre elettriche sembrava la cosa più simile al sollevarsi delle acque di cui potevo godere. E tutt’ora non riesco a immaginarne uno migliore per accompagnare quell’esatto istante della mia vita.
Nel GiveMe5 di oggi, memore di quella scena, ho scelto per voi cinque brani che – per ragioni e secondo modi differenti – racchiudono in sé il suono e il fascino del mare. Del resto, “come tutti sanno, meditazione e acqua sono sposate per sempre.”
Love From Room 109 (On The Pacific Coast Highway) | Tim Buckley (1969)
“Scrive Joanna Walsh in Hotel: niente accade mai davvero nelle camere d’albergo, nessuna tragedia, solo tempo che scorre uguale a se stesso. Nel suo saggio racconta di quando recensiva suites, lobby e camere doppie pur di non dormire a casa: il suo matrimonio stava finendo e il suo appartamento non faceva che ricordarglielo. Se il significato originale di hotel è quello di “casa, palazzo privato”, questo termine, col tempo, ha finito per indicare un altro tipo di alloggio, temporaneo, transitorio. Joanna Walsh vuole scrivere di hotel non perché desideri una nuova casa, ma, piuttosto, una forma più alta di oblio” (da un articolo su Il Tascabile di Sara Marzullo, questo)
D’accordo: la scelta più ovvia, quando si parla d’acqua e mare e Tim Buckley, sarebbe Song To The Siren. Sarebbe da chiamarla pure inflazionata, non fosse che quel brano acquatico è il più bello di uno dei dischi assoluti della storia di quella cosa che chiamiamo rock – definizione che peraltro al Nostro starebbe decisamente stretta.
Per una volta, invece che al culmine di quel percorso straordinario che portò Buckley – in soli tre anni – a cambiar pelle compiendo tutta la strada che separa un austero bardo folk da un navigatore delle stelle d’inimitabile coraggio, ho deciso invece di volgere lo sguardo al principio di quella fase sperimentale.
E allora parliamo di Happy Sad, il primo lavoro del cantautore che rende manifeste le influenze jazz incastonandole su luccicanti meditazioni folk.
Prima del delirio di Gypsy Woman – che evidentemente non c’entra nulla col resto dell’album, ma è così invasata che uno tende a non farci caso – e della dolente Dream Letter, c’è la canzone del mare che cercavo. Si chiama Love From Room 109 (On The Pacific Coast Highway), dura undici minuti ed è un’anticipazione di tutto quanto Buckley proporrà in scala ristretta su Blue Afternoon.
Naturalmente questo brano non parla di mare: parla d’amore e di sesso, e ne parla in maniera sensuale e indiretta sebbene il titolo sia accuratamente georeferenziato, diciamo (non sarà altrettanto sottile e suadente nei suoi album brutti che verranno dopo il 1970, appena prima della morte). Il pezzo è costruito su pochi elementi fondanti: il vibrafono di David Friedman, la chitarra di Lee Underwood e i bordoni di contrabbasso di John Miller, su cui planano gli accordi aperti della chitarra acustica e la voce di Buckley che sfarfalla un po’ dove le pare, anticipando quel lavoro sul vibrato e sull’aria che sarà alla base di Lorca.
Manca una cosa, a questo elenco, però.
Per tutta la durata di Love From Room 109 si sente in sottofondo il suono avanti-e-indietro delle onde dell’oceano che sembra accompagnare il movimento di corpi che si confondono uno nell’altro. È un suono vicinissimo, ed è facile immaginare le finestre della stanza 109 aperte, con il sole caldo del pomeriggio a illuminare la scena; ma non c’è nulla di romantico o bollente, qui, solo la malinconia di due anime che – giusto a pochi metri dall’acqua salata – cercano quiete da vite insoddisfacenti.
it’s my heart and your heart
it’s our hearts together
you sing and I’ll bring
we’ll both love together
and all I know is let it grow
all you’ll find is peace of mind
This Is The Sea | The Waterboys (1985)
these things you keep
you’d better throw them away
you wanna turn your back
on your soulless days
once you were tethered and now you are free
once you were tethered, well now you are free
that was the river, this is the sea!
This Is The Sea è il terzo album dei Waterboys, creatura del bizzoso Mike Scott, ed è uno di quei gloriosi misteri anni Ottanta che io ancora non mi spiego.
È un fatto che Scott non fosse proprio attento al marketing: quand’anche riusciva a scrivere singoli potenzialmente spaccaclassifiche come The Whole Of The Moon, poi comunque non si presentava a Top Of The Pops per suonarli. Ma pure così mi è difficile capire perché un capolavoro del genere – al pari del bellissimo A Pagan Place di un paio d’anni prima – non sia diventato un classico milionario quanto certe cose degli U2, cui si limiteranno a fare da supporto in tour per qualche tempo. Perché i Waterboys avevano tutto, e qui sono a fuoco per nove tracce indimenticabili.
Potremmo tranquillamente catalogare This Is the Sea alla voce folk-rock, ma la definizione più calzante rimarrà sempre quella di big music, una specie di enorme muro di suono applicato a tre influenze fondamentali: i Velvet Underground, Astral Weeks di Van Morrison, il minimalismo di Steve Reich. Fatelo partire, e dentro ci troverete fiati, archi, synth, batterie giganti come da copione eighties, acustiche tirate a lucido e una voce infuocata e passionale.
Poi, proprio alla fine, quasi tutto sparisce per lasciar posto a un wall of sound di sette chitarre acustiche sovraincise e poco altro, tappeto perfetto per il volo di Mike Scott. Ed è un’esortazione che si sgola per sei minuti e mezza e ci invita a non aver paura di tutto ciò che decideremo di provare a fare del nostro futuro.
Non importa quante guerre ci siano nella nostra testa, con quanti ricordi dolorosi siamo costretti a fare i conti ogni giorno, quanto sia difficile trovare un senso al presente quando il passato è un’ombra lunga, quanto siamo stati soli: quello era il fiume, questo è il mare.
now I hear there’s a train
it’s comin’ on down the line
it’s yours if you hurry, you’ve got still enough time.
and you don’t need no ticket and you don’t pay no fee
you don’t need no ticket and you don’t pay no fee
because that was the river and this is the sea
Submarine Bells | The Chills (1990)
since the weakest currents bruise it
someday i may lose this
immersed in words and miss you
kiss foaming waves goodbye
Non ero mai stato a Perugia di giorno, prima della scorsa settimana, e non c’è verso che io passi una giornata in una città che non conosca senza cercare un negozio di dischi: Alessandro mi aveva consigliato il T-Trane e mi ci sono fiondato subito.
Dentro, oltre a un ambiente splendidamente evocativo – in sottofondo, mentre ero lì, andava un minimalismo pianistico che non era Nils Frahm ma me l’ha ricordato moltissimo (a proposito: andatevelo a vedere dal vivo, se vi capita) – c’era ovviamente una quantità impressionante di vinili. Molti 60s e 70s, ma soprattutto una gran collezione di alternative dagli anni ottanta in poi: e lì in mezzo, nascosto, stava Submarine Bells dei neozelandesi Chills, disco indie sfigato della vita quant’altri mai. Ed è stato mio, subito.
Se volete saltare tutto il resto dell’album – cosa che vi sconsiglio vivamente: Heavenly Pop Hit, per dire, è esattamente ciò che il titolo promette (a parte la “hit”) – la canzone più bella sta proprio in fondo, ed è quella che gli dà il titolo.
Il tema è quello ecologista che s’intuisce nella maggior parte dei pezzi, una divorante ansia per le sorti degli ecosistemi marini. Nelle note di copertina si parla dei test a Mururoa, di Greenpeace, di dannosissimi metodi di pesca intensiva, della politica americana del “neither confirm nor deny” che impediva fra le altre cose a qualunque Stato concedesse il passaggio nelle proprie acque di sottomarini americani di sapere se questi portassero o meno con sé armi nucleari. E questo ben prima che tutti prendessimo coscienza di essere fottuti.
A livello di suoni, invece, è tutto diverso da quello che si è ascoltato prima. Qui non ci sono più le chitarre jangle-pop e la ritmica post-punk: solo una vocalità sinuosa e una melodia per archi e tastiere.
La voce e gli strumenti attaccano nello stesso momento, come se cogliessero un istante magico e irripetibile; come se creassero un mondo destinato a durare solo quei tre minuti, consapevoli che quella bellezza estatica è qui, ci affianca e – guardala laggiù! – è già passata. Il canto, sommesso e antispettacolare, funziona meravigliosamente, con parole che scivolano naturalmente una dentro l’altra e allitterazioni eleganti e mai esibite (le “s” del primo verso, bellissime); diventa quasi solo respiro, giusto uno strumento in mezzo agli altri.
E che dire di quell’arrangiamento d’archi, che porta con sé mille e una immagini di pura emozione.
Fa pensare di stare seduti al fondo del mare, Submarine Bells, a rimirare resti di una qualche civiltà perduta – magari una statua di tempi remoti, cui manchino diverse parti ma di cui ancora si possano riconoscere indizi di grandezza e di pura perfezione.
Ma quel suono è anche lo splendore ingenuo dell’esplorazione: come immergersi a profondità inaudite solo con una piccola luce a far da guida, con la speranza di trovare ancora là sotto, sana e salva, qualche creatura singolare e di bellezza inconsueta e nuova. Una bellezza che questo album si prende a cuore, dalla prima all’ultima nota.
deep and dark my submarine bells
groan in greens and grey
mine would chime a thousand times
to make you feel okay
Deep Waters | Dirty Three (1998)
Prima di diventare un pilastro dei Bad Seeds di Nick Cave, e dunque prima di farsi fulcro delle ultime creazioni monotone e mononota del Re Inchiostro – scusate, io la pasta sonora sciapa di Push The Sky Away e Ghosteen proprio non la reggo – Warren Ellis incendiava i palchi con i suoi Dirty Three.
Il violino elettrico acrobatico e violento dell’australiano, accompagnato dalle chitarre di Mick Turner e dalla batteria di Jim White, ha dato vita per un ventennio a una delle interpretazioni più poetiche del rock senza voce che io riesca a ricordare – qualcosa che puoi incontrare al crocevia tra la classica da camera, il folk-rock, il jazz e la psichedelia strumentale. E Ocean Songs è unanimemente considerato l’apice di quella parabola creativa, insieme al successivo e quasi altrettanto splendido Whatever You Love, You Are.
Concept dedicato al mare, il disco non si limita a una serie di brani che siano vagamente tematici. No: in Ocean Songs gli strumenti riproducono il suono della risacca, dell’innalzarsi e dell’abbassarsi delle maree, di marosi che tengono in ostaggio coste, cittadine, imbarcazioni e frastornano ribaltando la percezione di cosa stia sopra e cosa stia sotto. Il tutto per il solo tramite di una batteria spazzolata, del pianto di un violino affranto, timido e invece poi travolgente, degli accordi limpidi di una chitarra che non cerca mai la distorsione (laddove invece negli album precedenti, ancora acerbi, la sei-corde si abbandonava a veementi freakout che però sembravano nascondere momentanee mancanze d’ispirazione).
Deep Waters è il capolavoro.
Il tema portante diventa visibile effettivamente solo dopo sei minuti di preparazione, con il riff di Ellis pronto a ergersi maestoso su una base di due soli accordi di chitarra. Solo un breve cenno, però, perché tutto pare placarsi nella sezione intermedia – sentite come le spazzole della batteria mimino esattamente l’infrangersi di onde quiete sulla riva, la mattina presto. Giusto un attimo e poi si riparte con il tema principale espanso, amplificato come se ora ci fosse un’orchestra intera a suonarlo. O meglio: come se fosse proprio l’oceano a suonare se stesso.
Un’epopea straordinariamente sostenuta per tutta la propria durata. Una marea dalle tinte pastello di travolgente lirismo e altrettanto realismo, che i Dirty Three andranno a sciogliere in un brano in chiave minore – questa volta guidato dal pianoforte – come Ends Of The Earth. Come se si fosse giunti alle colonne d’Ercole di un viaggio impossibile da replicare.
Bound / And Boundless | Do Make Say Think (2017)
“È fantastico che siamo capaci di concettualizzare ogni cosa, perché questo ha trasformato quella che sarebbe stata solo un’altra specie di mammifero in quello straordinario super-organismo senziente che siamo. Ma riducendo continuamente la vita reale a una sua versione “verbale”, le cose iniziano a sembrarti un po’ vuote. E dato che siamo così abituati a ridurre le cose a concetti, finiamo per desiderare più concetti che esperienze reali. La musica strumentale, se la si riesce a sopportare, ci dà una pausa dalla nostra costante narrazione interiore, dalle chiacchiere dei nostri pensieri, e ci riporta alla nostra esperienza diretta” (da un’intervista a Vanyaland, questa)
Se dovessi scegliere un album per raccontare il mio viaggio in Croazia di un paio di estati fa – viaggio in auto quasi senza soste che non giovò granché alla mia relazione di allora – quello sarebbe di sicuro Stubborn Persistent Illusions, straordinario ritorno sulle scene di quel glorioso collettivo post-rock canadese chiamato Do Make Say Think. Un lavoro strumentale melodioso e giubilante, con tracce elaboratissime come da tradizione che per lunghi momenti dicono di una band letteralmente ubriaca di vita.
Momenti in cui lo sguardo si perde calmo nell’orizzonte e il tempo diventa non più così significativo, tanto da concedersi minuti che nell’economia di una vita non contano nulla se il punto del viaggio è esperire lo stare bene. Momenti in cui la ritmica si tuffa in acqua da qualche bel dirupo a picco sul mare – come quelli che avevo trovato a Trogir – o, giunta sulla cima di qualche arrampicata, rotola giù per i tornanti di qualche stradina stretta tra rocce e alberi. Come era stata la mia vacanza, così è questo disco meraviglioso.
Proprio in mezzo al percorso s’incontra una lunga suite divisa in due parti, Bound e And Boundless, che già dal titolo fa presagire una totale assenza di confini e limitazioni imposte da (pre)concetti e strutture – anche nel post-rock, genere che salvo casi illuminati come questo o i Godspeed You! Black Emperor si è spesso incastrato in schemi diventati subito vecchi e grigi.
Qui non succede, qui è tutto ampio e luminoso e azzurro, a partire dal sublime zampillare di chitarre in apertura che sfocia nell’ondeggiare trionfale del tema portante; una serenità messa in discussione giusto per un paio di minuti nel tempestoso break al principio della seconda sezione, che pian piano poi raddrizza la barra fino a riportare tutto in maggiore. Il mondo e l’esistenza osservati dall’albero maestro di una nave che rolla e beccheggia in mezzo all’oceano, memore del poemetto buddhista citato nel libretto:
when you lose your mind to something outside
be like the ship-captain watching her crow fly
with nowhere to alight on the boundless ocean
o winged companion, return, return again