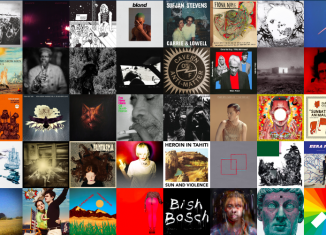Give Me 5 (Dream Pop Edition) | Vol. 118
“Come musicista, ti trovi spesso a dover rispondere alla domanda “che tipo di musica suoni?” e la risposta “dream pop” porta sempre sguardi perplessi. È un costrutto creato dopo gli eventi, non un movimento associato a uno specifico tempo, luogo o taglio di capelli. Forse è una categoria creata per band difficili da classificare. […] Le band shoegaze, ad esempio, somigliano più a un assalto, a un muro di sono, mentre nel dream pop c’è più spazio per la melodia e il contrappunto, sia esso nella voce, nelle tastiere o nelle chitarre.”
Parole di Dean Wareham, uno dei miei eroi musicali, incaricato da Pitchfork qualche settimana fa di introdurre una selezione di 30 dischi Dream Pop curata dai giornalisti della testata; genere musicale o categoria dello spirito dai confini labili e scivolosi quant’altri mai, dato che – come nota lo stesso Wareham – è stato negli anni associato alle esperienze sonore più svariate. Certo è che tutte le band tirate in ballo nell’articolo sembrano amare i grandi spazi, l’aria aperta, le melodie ampie ed eteree (anche se non necessariamente narcolettiche: per quelle ci si è inventati l’etichetta di slowcore).
Non so se avete mai visto Goodbye, Lenin, un piccolo film che fece molto parlare di sé quindici anni fa; la storia non sto a raccontarvela – molto meglio che la scopriate da voi – ma voglio dirvi di una scena che mi è rimasta particolarmente nel cuore. Siamo nella primavera del 1990 e il giovane protagonista e la sua innamorata, appena conosciuta, stanno a guardare la notte sorridendo al futuro in arrivo, le gambe a penzoloni nel vuoto di un edificio sventrato: Berlino, in quel preciso momento, è il posto più bello dell’universo. Quando penso al Dream Pop, io penso alla speranza ingenua di una notte in cui senti l’aria farsi elettrica sulla pelle, e allora è bello farsi cullare dalla poesia di melodie confortanti. Oggi, qui, ve ne racconto cinque.
Fade Into You | Mazzy Star
Hope Sandoval. La Nastassja Kinski dell’indie, la chiamava qualcuno nei gloriosi anni Novanta quando la sua bellezza ombrosa guidava i Mazzy Star con David Roback, uno che arrivava da anni di esperienza nel Paisley Underground più delicato (Rain Parade, Opal); per loro tre album di eccelsa qualità tra il 1990 e il 1996 e poi basta, fino alla reunion del 2013. Fade Into You sta in apertura del loro capolavoro, So Tonight That I Might See: giro di chitarra limpido, accompagnamento minimale e interpretazione scura e introversa – come dando le spalle all’ascoltatore – per uno degli slow più belli mai scritti, intriso di romanticismo dark e sonnambulo. Piccola nota per i patiti di serie tv: di recente, dallo stesso album, per The End Of The F****** World, si è rispolverata quell’altra meraviglia chiamata Five String Serenade.
Myth | Beach House
Spalancare una finestra in una mattina di sole: nelle orecchie un ticchettare pigro, negli occhi una luce abbagliante. Somiglia a questo, nella mia testa, Myth, la canzone che anticipava il lancio del quarto album dei Beach House, progetto che nell’ultimo decennio più si è qualificato come degno erede dei classici di un trentennio fa in materia di pop dei sogni. Poi i loro dischi potranno sembrarvi tutti uguali, per carità, ma ascoltarli – ancora oggi e anche dal vivo – è un’esperienza di pura gioia, resa ancora più intensa dalla voce di Victoria Legrand.
Fourth Of July | Galaxie 500
E torniamo a Dean Wareham, finalmente: non poteva certo mancare, nella selezione, uno dei grandi maestri della chitarra minimale – sia con i Galaxie 500, la band con cui ha fatto la Storia, sia poi coi Luna, ancora più essenziali. Fourth Of July è l’opener del disco in fondo meno riuscito dei Galaxie (questioni di lana caprina, ma This Is Our Music è troppo, troppo elaborato per chi aveva dato il meglio in dischi stringati come Today e On Fire), eppure si configura come uno dei loro classici definitivi: dolce e sussurrata, parlata più che cantata, con la sei-corde solo gentilmente distorta (mai un freakout fuori luogo, con Wareham) e – meraviglia! – una citazione di Candy Says dei Velvet Underground in chiusura. Alla fine, per dirla bene, basta il ritornello: “maybe I should just change my style, but I feel alright when you smile”.
Carolyn’s Fingers | Cocteau Twins
Nel cuore mio e di molti altri, i Cocteau Twins più grandi saranno per sempre quelli chiusi dentro alle dieci tracce di Treasure, pubblicato a fine 1984 (annus mirabilis in materia di pop/rock, e un giorno avremo modo di parlarne anche qui). Di fatto, però, si pesca bene quasi ovunque, nel loro periodo che parte da Head Over Heels e arriva fino all’altro capolavoro, Heaven Or Las Vegas – che si è giocato fino all’ultimo la possibilità di essere rappresentato qui dentro con Fotzepolitic. Alla fine ho scelto un grande, grandissimo singolo del 1988, Carolyn’s Fingers, una di quelle canzoni che conoscete per forza anche se non sapete chi la canta o come si chiama: il ritmo è costante, quieto e sicuro dall’inizio alla fine, mentre la chitarra di Robin Guthrie disegna una melodia perfetta per Elizabeth Fraser, voce operistica che non ha bisogno di parole per rendere il suono pura emozione.
Song To The Siren | This Mortal Coil
Per finire, This Mortal Coil. Che non era un semplice gruppo, ma un collettivo guidato da Ivo Watts Russell, fondatore della seminale casa discografica 4AD – seminale ancora oggi: pensate che dopo Pixies, Cocteau Twins, Red House Painters, Lisa Germano o Bauhaus, oggi pubblica The National, Deerhunter, Future Islands, Scott Walker e U.S. Girls. Il primo album, It’ll End In Tears, è fatto perlopiù di cover reinterpretate in chiave gotica e sognante: apice eterno Song To The Siren, una delle canzoni più belle della storia. Straordinariamente fedele in spirito e atmosfera acquatica all’originale di Tim Buckley, l’interpretazione di Elizabeth Fraser – sì, ancora lei, la divina – sarà quella che di fatto porterà a riscoprire l’opera di uno dei maggiori songwriter e vocalist dell’intero Novecento.