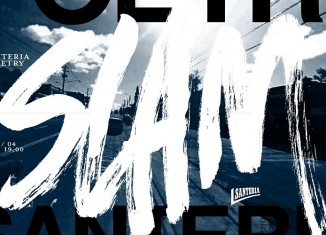This is America. Il senso dell’arte ai tempi di Donald Glover
Questa è la ragione per cui i film di genere hanno tanto successo: possono scuotere gli spettatori per un paio d’ore, così che poi siano tranquilli all’uscita dal cinema. E gli spettatori pagano per questo accordo. Considerando lo stato in cui versa il mondo, mi sembra un po’ irresponsabile. Il risultato è che il nostro bisogno di distrazione è soddisfatto, ma c’è il potenziale per fare di tutto questo qualcosa in più: rifiutando di dare sollievo agli spettatori, gli si lascia un rovello in testa. Questo è il mio scopo, in tutti i miei film. (Da un’intervista a Michael Haneke, questa)
Le date sono importanti, per me. Fissare momenti, mettere puntine su una linea temporale negli istanti in cui qualcosa di significativo stia succedendo è il modo che ho trovato per dare un senso all’esistenza: non è che si debba cercare l’epifania in ogni cosa (nonostante i nostri feed di Facebook e Instagram cerchino di convincerci del contrario), e però certi momenti ti offrono proprio la possibilità di unire i puntini, di avere un quadro complessivo, di dire “ah ok, quindi è così”. L’ultimo mi è capitato probabilmente il 24 novembre scorso: le mani cacciate al fondo delle tasche, io e Andrea camminavamo per Centocelle e la conversazione verteva – in poche parole – sulla fine del mondo così come lo conosciamo. Lungi dal voler sembrare dei Rorschach allucinati, è pur vero che il desolante quadro politico-sociale contro cui ci scontriamo ogni giorno – l’ultima, mentre scrivo, è quella di migranti *regolari* sbattuti in mezzo a una strada in nome della presunta sicurezza – sembra proprio dire che l’intero sistema di valori su cui si è basata la convivenza civile finora nelle nostre comode democrazie può essere spazzato via da un momento all’altro da una nuova barbarie.
A un certo punto è stato automatico farsi una domanda: cos’è che manca all’arte, oggi, per essere parte dell’opposizione a tutto questo orrore e non un semplice diversivo escapista o, nella migliore delle ipotesi, una descrizione? Capitavano a fagiolo le parole del regista austriaco Michael Haneke, citate qui sopra – Andrea stava scrivendo un pezzo sul capolavoro Niente da Nascondere e aveva scovato quest’intervista, che mi pare significativa per almeno due motivi, in questo contesto:
- il cinema di Haneke affronta di petto il tema della responsabilità che noi spettatori abbiamo quando restiamo compiaciuti da una violenza rappresentata e non stiamo a domandarci quali conseguenze si porterebbe dietro quell’esatta violenza fuori da quello schermo. Niente da Nascondere o Funny Games sono una mostra delle atrocità fisica e psicologica, ancor più tremenda poiché perfettamente realistica – niente di cartoonesco nel suicidio di Majid, una scena cui si ripensa ad anni dalla prima visione; niente che abbia a che fare con il cinico disprezzo con cui sotterriamo ogni giorno sui social network la riflessione sull’umana sofferenza.
- Ci siamo abituati ai popcorn e tanto ci basta: la formula “cultura pop” è quella che ci serve per ingollare serie tv, film e canzoni che nulla hanno da dire sull’epoca che viviamo, prodotti che ci intrattengono giusto per la loro durata e funzionano da anestetico – esteticamente inattaccabile, ma pur sempre un anestetico. Nulla di provocatorio, disturbante, che resti anche dopo.
È stato allora che Andrea se n’è uscito ricordando il video più importante del 2018. “Magari non se lo ricorderà nessuno l’anno prossimo”, ha detto, ma io non ci credo: This Is America di Donald Glover ha tutti i crismi del classico, un’opera che risponde appunto alla richiesta di un’arte che sappia non solo dire e intrattenere, ma pure provocare, colpire, lasciare un segno.
Il 5 maggio Donald Glover presenta il Saturday Night Live con questo divertente monologo; più avanti nella serata, vestiti i panni dell’alter ego musicale Childish Gambino, propone un nuovo pezzo dal titolo This Is America: il relativo videoclip sarà pubblicato solo qualche ora dopo su Youtube e quindi, mentre la trasmissione va in onda, l’America e il mondo ancora non sanno cosa li aspetta. In quel preciso frangente, Glover incarna alla perfezione la catch-phrase sbruffona e autoironica canticchiata durante l’intro: davvero sembra che l’attore/cantante possa fare qualunque cosa, ma sempre con quel certo margine di sicurezza che spesso lo fa sembrare un enorme talento che per la maggior parte del tempo traccheggi. Due esempi? Prendete il suo Troy Barnes in Community, serie geniale, ma fin troppo consapevole e compiaciuta della propria eccentricità; prendete lo strepitoso album “Awaken, My Love!”, quello che lo ha traghettato dal puro hip-hop a lidi soul/funk psichedelici e totalmente black. Cose splendide, che ricorderemo perché ci hanno divertito, ma dalla qualità pari solo alla paraculaggine. Poi, però, è arrivata Atlanta.
Non voglio che la gente rida come se ridesse davanti agli animali in gabbia allo zoo. Voglio che percepisca davvero il razzismo, che senta davvero cosa significhi essere neri in America. La gente arriva ad “Atlanta” per gli strip club, la musica, i discorsi fighi, ma la parte istruttiva è che i personaggi non fumano erba perché è cool, ma perché hanno un disturbo da stress post-traumatico. Ogni nero ce l’ha. (Da un’intervista a Donald Glover sul New Yorker, questa)
Mi tolgo subito un sassolino dalla scarpa: insieme a Bojack Horseman, Atlanta è la serie più bella e importante di questi anni in cui la produzione di serie è esplosa definitivamente; Glover ne è il deus ex machina: l’ha prodotta e ci ha recitato, oltre a scrivere molti episodi e a girarne alcuni altri. La trama è scarna e presto detta: Earn (Glover, appunto) cerca di riciclarsi come manager del cugino rapper Paper Boi (Brian Tyree Henry) e parallelamente di far funzionare la relazione con Van (Zazie Beetz). Non che la trama sia anche solo lontanamente il punto – se lo fosse stato, se Atlanta avesse semplicemente voluto raccontare una storia lineare, non avremmo avuto Lakeith Stanfield a filosofeggiare in primo piano; il punto, qui, è invece raccontare quell’esperienza collettiva che va sotto il nome di black trauma per il tramite di una serie di illuminazioni apparentemente scollegate e alcuni topoi ricorrenti ed esemplificativi di quel mondo: il rap, lo spaccio di droga, l’uso e l’abuso di marijuana, la violenza repressa, il carcere come passaggio obbligato, la depressione e l’implosione, perfino il negozio del barbiere.
La prima stagione – due Emmy per Glover, sia come attore che come regista – scorre ancora su binari canonici, non fosse scossa qui e là da spostamenti di prospettiva che squassano il realismo della narrazione (pure Justin Bieber è un afroamericano, in Nobody Beats the Biebs; Montague è una finta trasmissione televisiva in cui viene intervistato Paper Boi nell’incredibile episodio B.A.N.). È però con due puntate della seconda stagione che il genio allucinato dell’autore esplode con la potenza di un Get Out al cubo, giusto alcune settimane prima che This Is America vada in onda: in Teddy Perkins, Glover passa tutto il tempo a parlare in uno strambo falsetto e nascosto sotto coltri e coltri di trucco per sembrare un maschio bianco sessantenne in preda al delirio, mentre la trama sfrutta un vecchio pianoforte dai tasti colorati a mo’ di MacGuffin; in Woods (in cui a onor del vero il nostro si fa completamente da parte) Paper Boi viene aggredito da una gang: la violenza esplode in maniera così improvvisa che lo spettatore non ha più la minima certezza – così tipica dei prodotti patinati che Netflix sforna in serie, per dire – che uno dei personaggi centrali della serie sopravviva. Ecco: a ben vedere tutto il senso di This Is America stava già in queste due folgorazioni.
Nel seminale saggio Manifesto del Surrealismo, André Breton descrive il surrealismo come una risoluzione di ciò che appare, a prima vista, come una contraddizione tra gli stati del sogno e della realtà in “una sorta di realtà assoluta, di surrealtà”. Data questa definizione, il surrealismo sembra uno strumento più che adatto a descrivere parte del trauma della vita dei neri, capace di fornire dei mezzi per ritrarre ciò che può sembrare insieme un incubo fuori dal mondo e un luogo fin troppo comune. (Da un articolo del Guardian, questo)
Comincia solare, il pezzo: un arpeggio di chitarra da spiaggia e voci afro, mentre Donald Glover è a distanza, di spalle; in primo piano c’è l’artista Calvin The Second, sorridente e pacioso alla sei corde. Inizia a muoversi e gli si avvicina, il corpo rilassato in un frame e scosso da contrazioni spastiche in quello immediatamente successivo. Ci si aspetta qualcosa, certo, ma non che – estratta una pistola e in posa caricaturale da Jim Crow – Glover freddi il chitarrista (ora con cappuccio bianco in testa) con un colpo a bruciapelo alla nuca; e pure la canzone cambia in un soffio, affondata da un cupo beat trap. Solo qualche secondo e ripartono le danze di gruppo, prima che a cadere sotto i colpi di un fucile d’assalto sia un intero coro gospel, la parete sullo sfondo ritinteggiata a sangue; subito dopo fanno irruzione le forze di polizia e si scatena definitivamente il caos, fino al sorprendente doppio finale – la gente fugge urlando, Glover s’accende una canna e prende a ballare come un ossesso sul tettuccio di un’auto mentre ancora una volta ritorna giocoso il tema iniziale (e fateci caso: ogni volta che ritorna, suona sempre più stridente nel contesto in cui è utilizzato); nella scena successiva, lo sguardo terrorizzato fisso in macchina, il nostro scappa nel buio da quel delirio verso non si sa bene dove, accompagnato da una melodia regolata dall’autotune.
Chiariamo una cosa. This Is America, a livello puramente musicale e lirico, non è HUMBLE, né Donald Glover un nuovo Kendrick Lamar. Non c’è nulla di intrinsecamente favoloso nel pezzo in sé, che è semplicemente un gran singolo fatto apposta per farsi ricordare – tra l’altro anche con un’infinità di ad lib di gente famosa. Ma poi c’è quel video che nasconde così tanti dettagli da restituire un risultato finale infinitamente superiore alla somma delle parti.
Hiro Murai – già collaboratore di Glover in molti episodi di Atlanta – regala una regia fluida alle coreografie di Sherrie Silver e alle contorsioni del protagonista, che qui è autentico mattatore (e d’altra parte nel monologo del SNL si definiva una tripla minaccia, no?). Su queste basi solide poggiano concetti pesanti, pesantissimi: la violenza della polizia e il possesso di armi da fuoco, così diffuso negli USA; l’intorpidimento generalizzato delle coscienze, con i ragazzini che vedono ogni violenza filtrata dallo schermo di uno smartphone e noi stessi, pubblico assuefatto ormai a ogni tipo di rappresentazione di un male che – come nuova normalità – scorre davanti ai nostri occhi tra una foto di gattini e un cane-del-buongiornissimo; la leggerezza dei balli come simbolo dell’unica maniera in cui i bianchi riescano ad accettare dei neri in posizioni di potere e come arma di distrazione di massa dal dramma quotidiano che è la black life suburbana: succedono cose, là dietro – figure incappucciate a cavallo, gente che cade dalle impalcature, urla – ma non ci fai caso, perché tutto è studiato per rendere sfondo ciò che invece dovrebbe essere centrale. Esattamente il motivo per cui siamo partiti da Michael Haneke, anche se quello che nel regista austriaco è iperrealismo qui diventa surrealismo: quale che sia il tono, l’esito è un’opera d’arte dall’impatto devastante, che non smette di destare stupore a ogni visione e suscitare nuove domande. L’abbiamo già visto mezzo miliardo di volte dall’inizio di maggio, questo video, e continueremo a farlo, schiantati da quei colpi d’arma da fuoco imprevisti che mirano alle coscienze e ricordano la violenza insensata e l’agghiacciante indifferenza della nostra epoca.
Il video è già stato descritto come un potente grido di protesta contro la violenza armata, un potente ritratto dell’esistenzialismo afroamericano, una potente accusa rivolta a una cultura che fa circolare video di bambini neri che muoiono tanto facilmente quanto lo fa con video di bambini neri che ballano in un parcheggio. È certamente tutte queste cose, ma anche un documento fondamentalmente ambiguo. La verità è che questo video, e ciò che suggerisce riguardo al suo autore, è molto difficile. Molte persone di colore lo detestano. Glover ci costringe a vivere nuovamente dei traumi pubblici e ci dà giusto un secondo per prendere fiato prima che ci obblighi di nuovo a ballare.
C’è un ineludibile disprezzo cucito nel tessuto di “This Is America”. Il fatto stesso che le scene di ballo vengano già sminuzzate online in divertenti piccole GIF, separate dalla brutalità del video, serve solo a dimostrare il suo punto. (Da un articolo del New Yorker, questo)
EXTRA. 12 cose sul mondo intorno a This is America
ASCOLTARE
To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar, 2015
DAMN., Kendrick Lamar, 2017
“Awaken, My Love!”, Childish Gambino, 2016
Channel Orange, Frank Ocean, 2012
Funkentelechy vs The Placebo Syndrome, Parliament, 1977
GUARDARE
B.A.N. (Atlanta, Stagione 1, Episodio 7), scritto e diretto da Donald Glover, 2016
Teddy Perkins (Atlanta, Stagione 2, Episodio 6), scritto da Donald Glover e diretto da Hiro Murai, 2018
Woods (Atlanta, Stagione 2, Episodio 8), scritto da Stefani Robinson e diretto da Hiro Murai, 2018
Get Out, scritto e diretto da Jordan Peele, 2017
Rodney King, scritto da Roger Guenveur Smith e diretto Spike Lee, 2017
LEGGERE
La Ferrovia Sotterranea, Colson Whitehead, 2016
Tra Me e il Mondo, Ta-Nehisi Coates, 2015